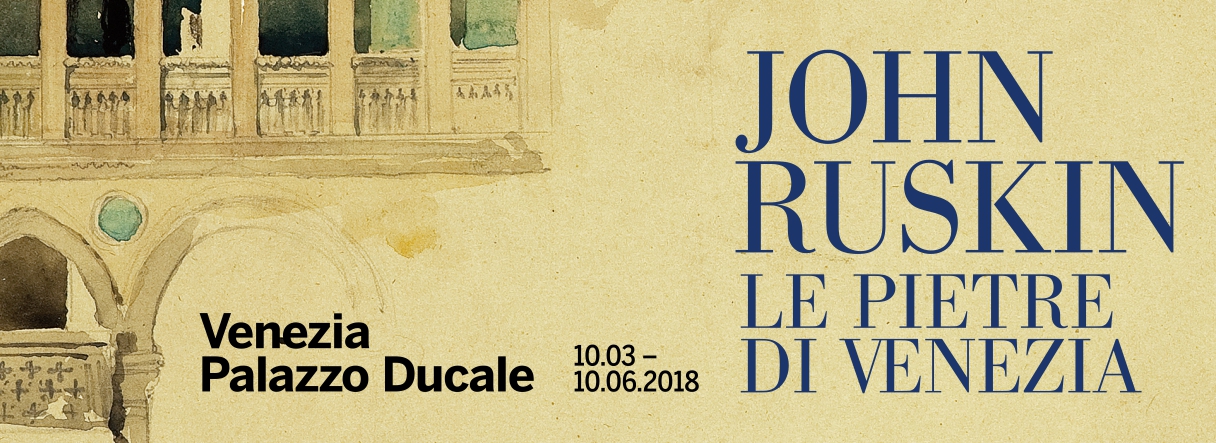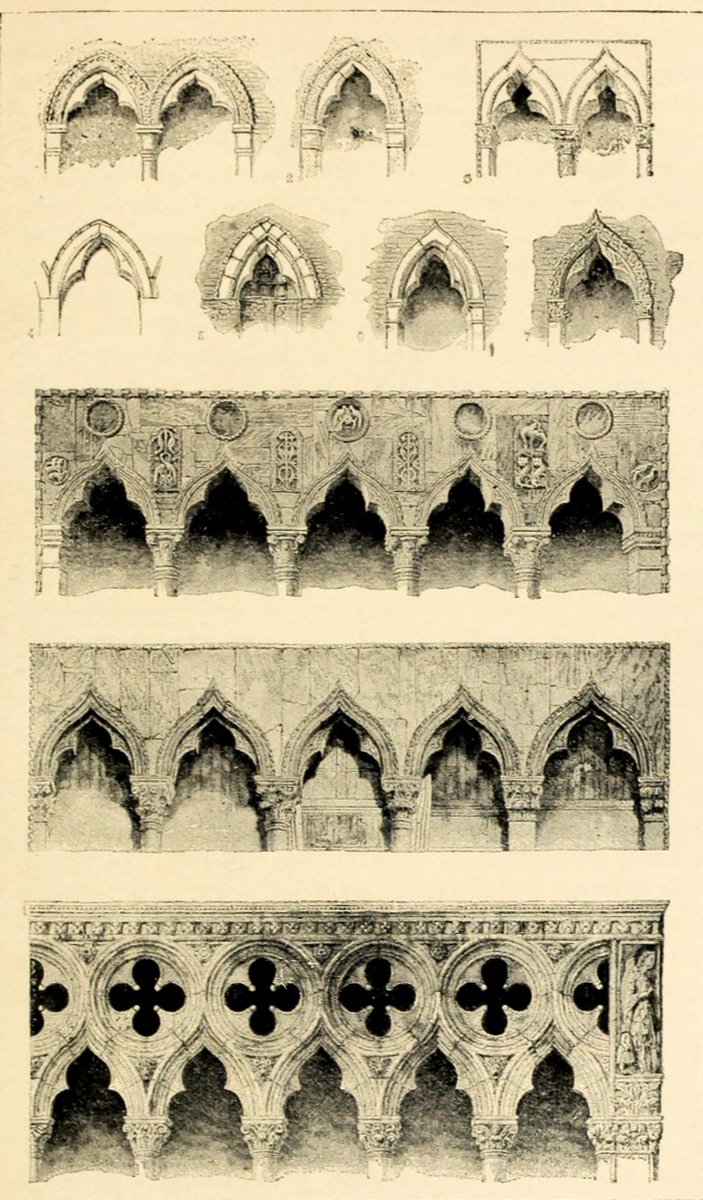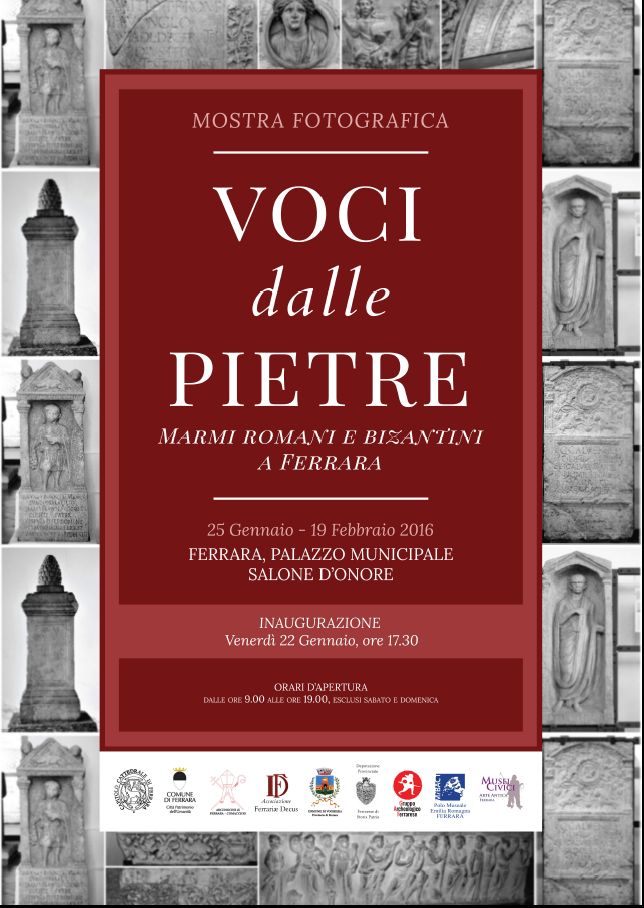In
occasione dei 2.200 anni dalla fondazione di Aquileia, il Museo dell’Ara Pacis ospita la mostra “Aquileia 2.200”, importante evento
espositivo che intende ripercorrere le “trasformazioni” della Città nei
suoi momenti storicamente più significativi, l’antica città
romana, l’Aquileia bizantina e medievale, il Patriarcato e la Chiesa
aquileiese, sino a giungere al periodo in cui la città fu parte
dell’Impero asburgico ed infine agli anni della Prima Guerra Mondiale e
del successivo dopoguerra.
Nata dalla collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, la Fondazione Aquileia e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
la mostra riunisce alcune importantissime opere d’arte romana
provenienti dal Museo Archeologico Nazionale - tra cui l’iconica “Testa
del Vento” bronzea - e circa trenta calchi di reperti aquileiesi
provenienti dal Museo della Civiltà Romana e realizzati nel 1938 in
occasione della Mostra Augustea della Romanità, laddove Aquileia era la
città più rappresentata insieme a Pompei e Ostia.
Cinquanta splendide fotografie scattate 40 anni fa dal Maestro Elio Ciol, attualmente esibite al MAMM di Mosca, saranno un importante contributo di multimedialità che renderà molto coinvolgente la visita alla mostra.
A corredo della mostra sarà proiettato in “loop” in zona appositamente attrezzata nel percorso espositivo il filmato sui primi due millenni di Aquileia realizzato da 3D Produzioni con l’apporto di materiali dell’Istituto Luce.
Oltre che celebrare i 2.200 anni di storia dell’antica città romana, la mostra vuole sottolineare l’importanza del rapporto Aquileia-Roma e la straordinaria capacità di palingenesi di una città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti, la cui esistenza ha avuto un significato non solo militare, politico ed economico per oltre due millenni, ma anche culturale e ideale nel bacino del Mediterraneo e nel rapporto tra Oriente e Occidente.
Per secoli Aquileia è stata il porto più a settentrione dell’intero Mediterraneo e ha costituito la porta d’entrata di merci, arte e idee provenienti da Nord Africa e Medio Oriente che, rielaborate e metabolizzate, da Aquileia si sono diffuse nell’Italia Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum.
Da sabato 9 novembre a domenica 1 dicembre 2019
Cinquanta splendide fotografie scattate 40 anni fa dal Maestro Elio Ciol, attualmente esibite al MAMM di Mosca, saranno un importante contributo di multimedialità che renderà molto coinvolgente la visita alla mostra.
A corredo della mostra sarà proiettato in “loop” in zona appositamente attrezzata nel percorso espositivo il filmato sui primi due millenni di Aquileia realizzato da 3D Produzioni con l’apporto di materiali dell’Istituto Luce.
Oltre che celebrare i 2.200 anni di storia dell’antica città romana, la mostra vuole sottolineare l’importanza del rapporto Aquileia-Roma e la straordinaria capacità di palingenesi di una città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti, la cui esistenza ha avuto un significato non solo militare, politico ed economico per oltre due millenni, ma anche culturale e ideale nel bacino del Mediterraneo e nel rapporto tra Oriente e Occidente.
Per secoli Aquileia è stata il porto più a settentrione dell’intero Mediterraneo e ha costituito la porta d’entrata di merci, arte e idee provenienti da Nord Africa e Medio Oriente che, rielaborate e metabolizzate, da Aquileia si sono diffuse nell’Italia Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum.
Da sabato 9 novembre a domenica 1 dicembre 2019
Tutti i giorni ore 9.30 – 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima).