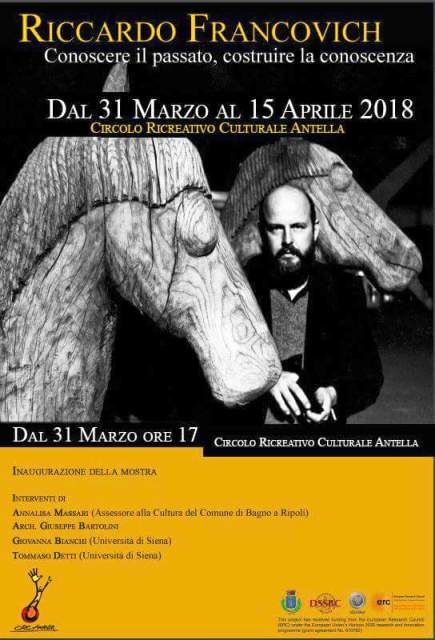Nel 2018 2200 anni lungo la Via Emilia, il programma culturale
organizzato in occasione della ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione
romana di Modena, Parma e Reggio Emilia, aggiunge alle celebrazioni una
mostra di archeologia a Bologna sul medioevo emiliano-romagnolo. Il
capoluogo regionale, infatti - da sabato 17 febbraio a domenica 17 giugno 2018 -
ospita al Lapidario del Museo Civico Medievale l'esposizione "Medioevo
svelato. Storie dell’Emilia-Romagna attraverso l’archeologia" a cura di
Sauro Gelichi (Professore Ordinario di Archeologia Medievale,
Dipartimento Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia) e di
Luigi Malnati (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara).
La mostra, promossa da Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara in collaborazione con Istituzione Bologna Musei
| Musei Civici d'Arte Antica, intende offrire una panoramica del
territorio regionale attraverso quasi un millennio di storia, dalla
Tardantichità (IV-V secolo) al Medioevo (inizi del Trecento).
L’Emilia-Romagna, infatti, fornisce una prospettiva di ricerca
privilegiata per la comprensione di fenomeni complessi che investono non
solo gli aspetti politici, sociali ed economici, ma la stessa identità
culturale del mondo classico nella delicata fase di passaggio al
Medioevo.
Il percorso espositivo si articola in sei sezioni tematiche. La I
sezione è incentrata sul tema della Trasformazione delle città, ossia
sull’evoluzione dei centri di antica fondazione in rapporto ai
cambiamenti socio-economici e all’organizzazione delle nuove sedi del
potere (laico ed ecclesiastico).
La II sezione, imperniata sulla Fine delle ville, prende in esame
l’insediamento rurale di tipo sparso, già tipico delle fattorie di età
romana.
I grandi mutamenti e, in particolare, l’ideologia funeraria di VI-VII
secolo, caratterizzano la III sezione dedicata a Nuove genti, nuove
culture, nuovi paesaggi: in tale periodo l’Emilia-Romagna consente di
rilevare la sostanziale continuità tra età romana e gota - Parma, Imola
(ricco corredo da Villa Clelia), Bentivoglio (Bologna) - e la forte
differenziazione tra territori soggetti ai Longobardi (Emilia) e ai
Bizantini (Romagna, qui rappresentata da Faenza e da Rimini).
Allo sfarzo di alcuni manufatti afferenti alle sepolture fanno
riscontro i pochi materiali recuperati nei contesti urbani regionali –
Fidenza (Parma), Rimini e Ravenna - della IV sezione dedicata a Città ed
empori nell’alto Medioevo. All’opposto, spicca per vitalità e capacità
economiche il più grande emporio del nord Italia nel secolo VIII,
Comacchio (Ferrara), strategico centro lagunare aperto, in cui l’acqua
gioca il ruolo fondamentale di via di comunicazione, trasporto e
smistamento di merci e di beni mediterranei destinati alle terre del
Regno longobardo.
Con la V sezione Villaggi, castelli, chiese e monasteri: la
riorganizzazione del tessuto insediativo vengono evidenziate le nuove
forme d’insediamento (VIII-XIII secolo), quali i castelli, i villaggi di
pianura, talvolta fortificati, i borghi franchi, le chiese rurali,
perfettamente integrate nella rete itineraria e il ruolo dei monasteri,
incaricati del perpetuarsi della memoria dei defunti e della
trasmissione della cultura.
Il racconto termina ciclicamente - grazie alla VI sezione incentrata
su Dopo il Mille: la rinascita delle città, con il ritorno al tema
dell’evoluzione dei centri urbani, studiati nella nuova fase di età
comunale: Parma e Ferrara (di cui sono esposti oggetti di straordinario
valore, perché conservati nonostante la deperibilità del materiale, il
legno), Rimini e Ravenna, caratterizzate da rinnovato dinamismo e
Bologna, rappresentata dalla più antica croce viaria lapidea (anno
1143), recuperata nel 2013 sotto il portico della chiesa di Santa Maria
Maggiore (via Galliera).
Le storie dell’Emilia-Romagna si concludono a Bologna con altri
eccezionali rinvenimenti dall’ex Sala Borsa e dalla chiesa di San
Giacomo Maggiore, edificio alla sommità del quale sono stati recuperati -
dalla collocazione originaria - i bacini (piatti) in maiolica databili
agli inizi del XIV secolo. In quest’ultimo caso, oltre alla
testimonianza di una vocazione decorativa specificamente programmata e
realizzata a Bologna, emerge la figura emblematica del ritratto, in uno
di questi contenitori, di frate Simone, identificabile molto
probabilmente con l’omonimo sindaco del convento di San Giacomo.
Medioevo svelato, che allarga il raggio di azione del progetto
complessivo a tutta l'Emilia-Romagna offre una particolare promozione
per il pubblico legata alla Card Musei Metropolitani Bologna: grazie a
una convenzione tra i Comuni di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia, i
possessori della Card avranno diritto all'ingresso con biglietto
ridotto alle mostre Mutina splendidissima (Modena, Foro Boario, 26
novembre 2017 - 8 aprile 2018) e On the road. Via Emilia 187 a.C. - 2017
(Reggio Emilia, Palazzo dei Musei, 24 novembre 2017 - 1 luglio 2018).
Reciprocamente, i possessori di biglietto delle due esposizioni di
Modena e Reggio Emilia avranno diritto alla riduzione sul titolo
d'ingresso per la mostra al Museo Civico Medievale di Bologna.
La partnership attivata al di fuori dall'area metropolitana di
Bologna permette di rendere effettiva, anche grazie alla comunicazione e
informazione congiunta di tutte le iniziative del progetto 2200 anni
lungo la Via Emilia, l'idea di rete culturale e di museo diffuso sul
territorio che è alla base della Card Musei Metropolitani, abbonamento
annuale che consente l'accesso illimitato alle collezioni permanenti e
offre riduzioni per le mostre temporanee dei musei aderenti al circuito.
Orari di apertura:
fino al 28 febbraio 2018
dal martedì al venerdì h 9.00 – 18.30
sabato, domenica e festivi h 10.00 – 18.30
chiuso lunedì feriali
dal 1 marzo 2018
dal martedì alla domenica h 10.00 – 18.30
chiuso lunedì feriali, 1° maggio
Ingresso:
intero € 5 | ridotto € 3 | gratuito Card Musei Metropolitani Bologna e la prima domenica del mese
Twitter: @MuseiCiviciBolo




 Il
progetto, curato dall'architetto Barbara Fiorini con il Comune di
Grosseto capofila, è condiviso con la Diocesi di Grosseto, la
Soprintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio delle province di
Siena Grosseto Arezzo, la Facoltà di Agraria dell’Università la Sapienza
di Pisa, Fondazione Grosseto Cultura, la Facoltà di Archeologia di
Siena (sede distaccata di Grosseto), la Società Speleologica
Naturalistica Maremmana, il Polo Museale della Toscana, l'Ente Parco
Regionale della Maremma, ClarisseArte, Terre Regionali Toscane,
Promocultura oltre ad altri partners privati coinvolti fin da subito in
questo lavoro.
Il
progetto, curato dall'architetto Barbara Fiorini con il Comune di
Grosseto capofila, è condiviso con la Diocesi di Grosseto, la
Soprintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio delle province di
Siena Grosseto Arezzo, la Facoltà di Agraria dell’Università la Sapienza
di Pisa, Fondazione Grosseto Cultura, la Facoltà di Archeologia di
Siena (sede distaccata di Grosseto), la Società Speleologica
Naturalistica Maremmana, il Polo Museale della Toscana, l'Ente Parco
Regionale della Maremma, ClarisseArte, Terre Regionali Toscane,
Promocultura oltre ad altri partners privati coinvolti fin da subito in
questo lavoro. Il
luogo ove saranno raccolti tutti i materiali recuperati e restaurati è
il
Il
luogo ove saranno raccolti tutti i materiali recuperati e restaurati è
il