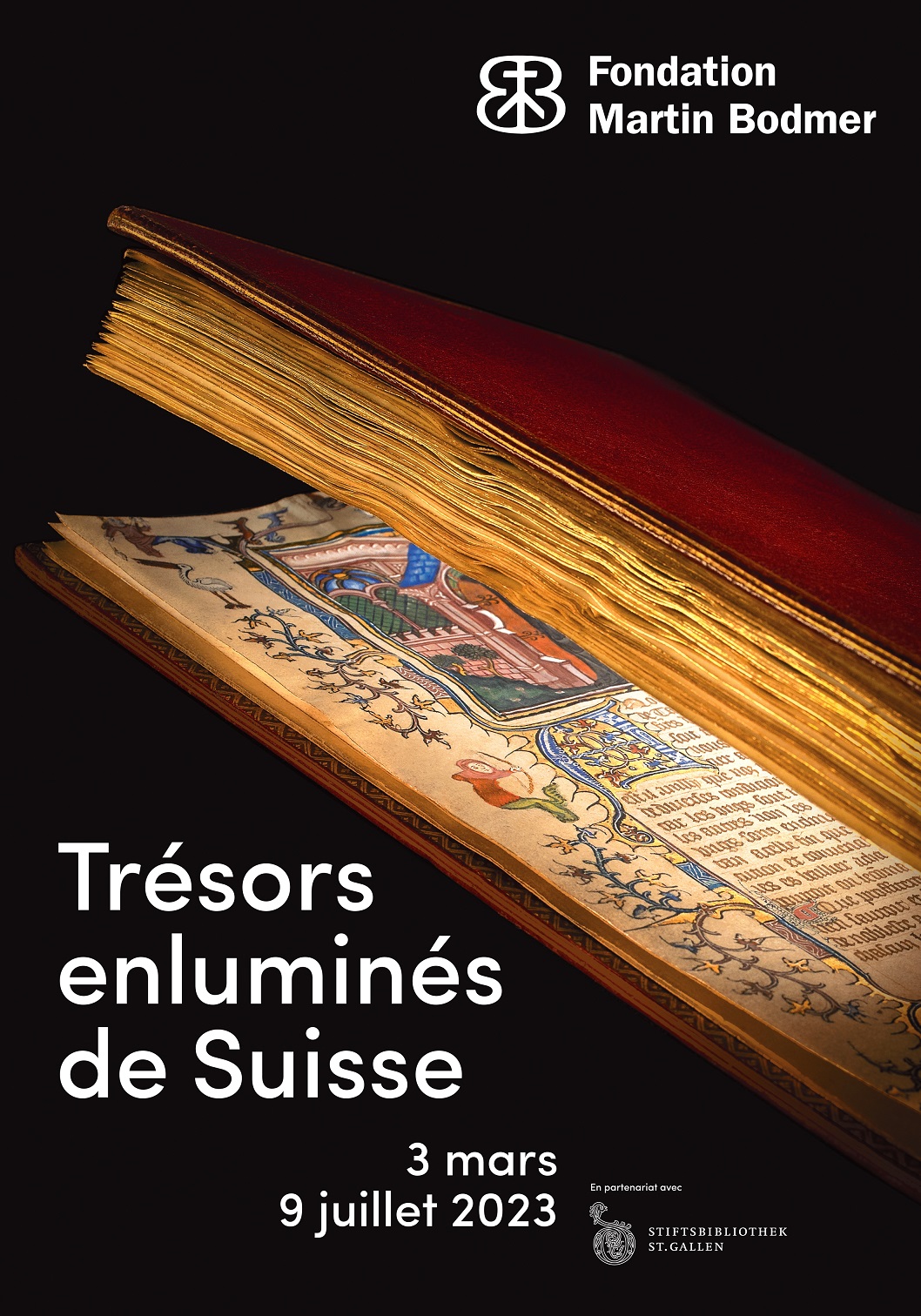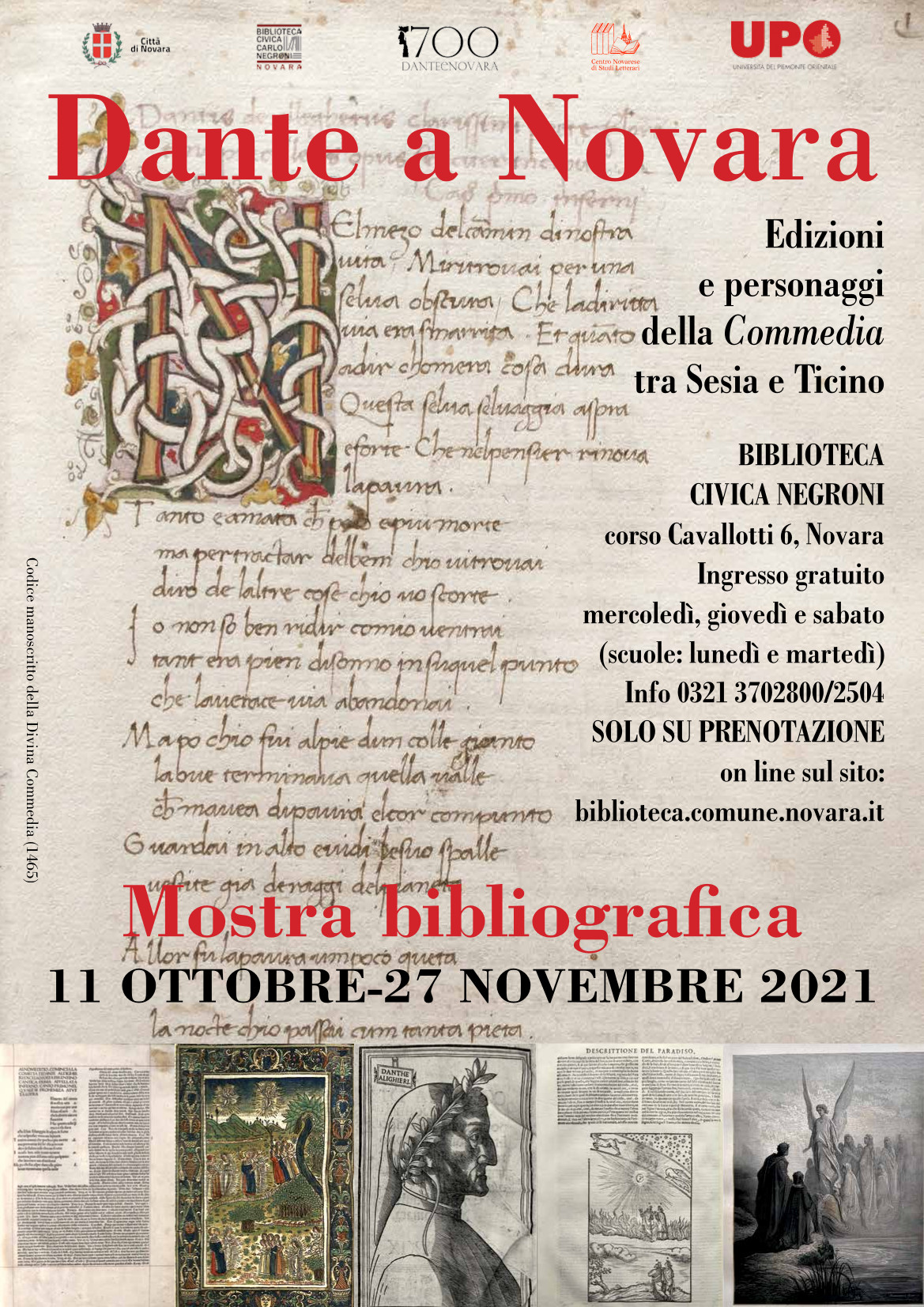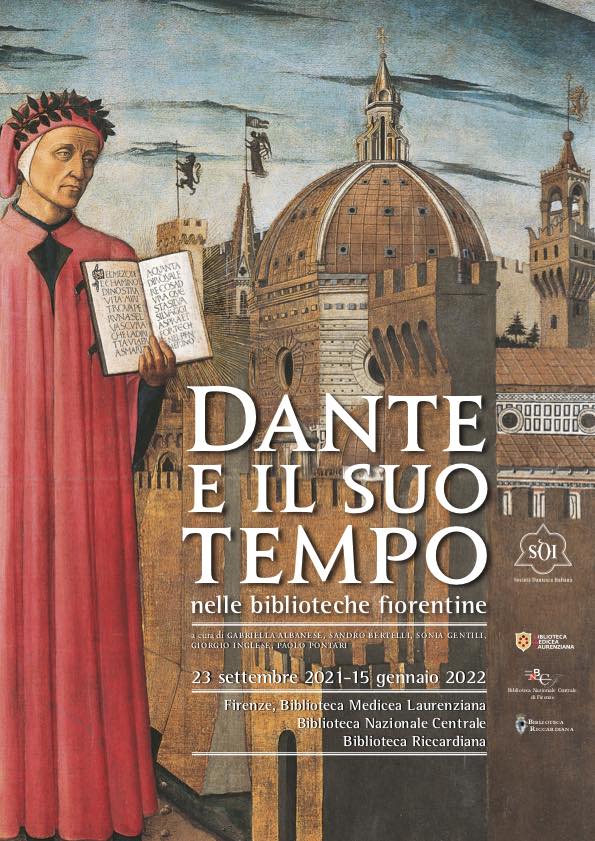Nell’anno del Signore 517
Verona al tempo di Ursicino
Crocevia di uomini, culture e scritture
Sabato 17 febbraio – mercoledì 16 maggio 2018
Il primo agosto del 517, chino sul suo scrittoio, in un silenzio che
immaginiamo afoso per la vicinanza delle acque dell’Adige, il chierico
Ursicino finiva di scrivere un libro per la cattedrale veronese. Nel
farlo, con un gesto che pochi praticavano in quei tempi, ci mise la
firma e la data. Poi, quel libro con le vite di Martino, vescovo di
Tours, e di Paolo, monaco nella Tebaide, finì sullo scaffale: libro tra i
libri, unico tra molti altri pezzi unici.
Cosa c’è di straordinario, dunque, nella storia di
questo libro “ordinario”? Semplice: c’è che la grandissima parte dei
libri scritti più di mille e cinquecento anni fa in Occidente è
scomparsa da secoli: roghi, allagamenti, censure, bombardamenti,
sottrazioni dolose, razzie e furti hanno fatto il loro indifferente
lavoro di distruzione. Il libro di Ursicino, assieme agli altri che gli
si sono depositati accanto, invece, no. La sede in cui ancora oggi sono
conservati, dalla quale non si sono mai mossi, li ha salvati da ciascuno
di quegli agenti di distruzione e li ha portati fino a noi.
Queste schegge del nostro comune (seppure remoto)
passato sono in qualche modo dei viaggiatori del tempo, dei
sopravvissuti più unici che rari (questo è davvero il caso di dirlo),
pronti a far sentire la propria voce da distanze millenarie, a
raccontare in modo appassionante, più che documentare con tono neutro,
la storia che li ha generati.
Ciascuno di quei libri, anzi, ha una sua
storia da raccontare di quel secolo, il VI (il 501 e il 600 sono gli
estremi “ufficiali), che vide la fine definitiva dello “stato” romano e
lo sforzo creativo di inventarsi un’alternativa nel bel mezzo di un
inedito “scontro di civiltà”.
 |
| Il libro di Ursicino |
Per ricordare e celebrare i mille e cinquecento anni
del libro di Ursicino, la Biblioteca Capitolare ha deciso di
dissigillare questi millenari superstiti, esporli e lasciare che le loro
storie incontrino nuovi ascoltatori. Perché? Beh, perché queste storie
raccontano da un’angolazione unica com’è fatto il mondo in cui viviamo e
cosa esso può, in determinate condizioni, diventare.
Un’occasione da non perdere per conoscere il passato
direttamente dalla “voce” degli oggetti che lo hanno attraversato,
capire il presente che essi hanno contribuito a costruire e immaginare
uno almeno dei futuri possibili che ci attendono.
Biglietti, orari e visite guidate
La Biblioteca Capitolare si trova a Verona, in Piazza Duomo numero 19
Orari di apertura al pubblico (ingresso mostra senza guida)
Da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Biglietto € 5,00
Ingresso gratuito fino ai 14 anni
Orari di apertura al pubblico (con visita guidata)
Sabato dalle ore 16.00 alle 18.00*
Domenica dalle ore 10.00 alle 13.00*
Biglietto € 10,00 (ingresso mostra con guida + entrata libera al museo e al chiostro del Capitolo dei Canonici)
Ingresso gratuito fino ai 14 anni
*visita guidata ogni 45 minuti. La prenotazione non è obbligatoria, ma dà diritto alla priorità d’accesso.
Biglietti gruppo scolastico
€ 4,00 a partecipante per gruppi scolastici di almeno 15 persone.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: info@capitolareverona.it 045 8538071 – 388 5758902
dal lun. al giov. Dalle 8.00 alle 17.00, venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00
Per maggiori informazioni e visitare il sito dedicato alla mostra clicca qui !